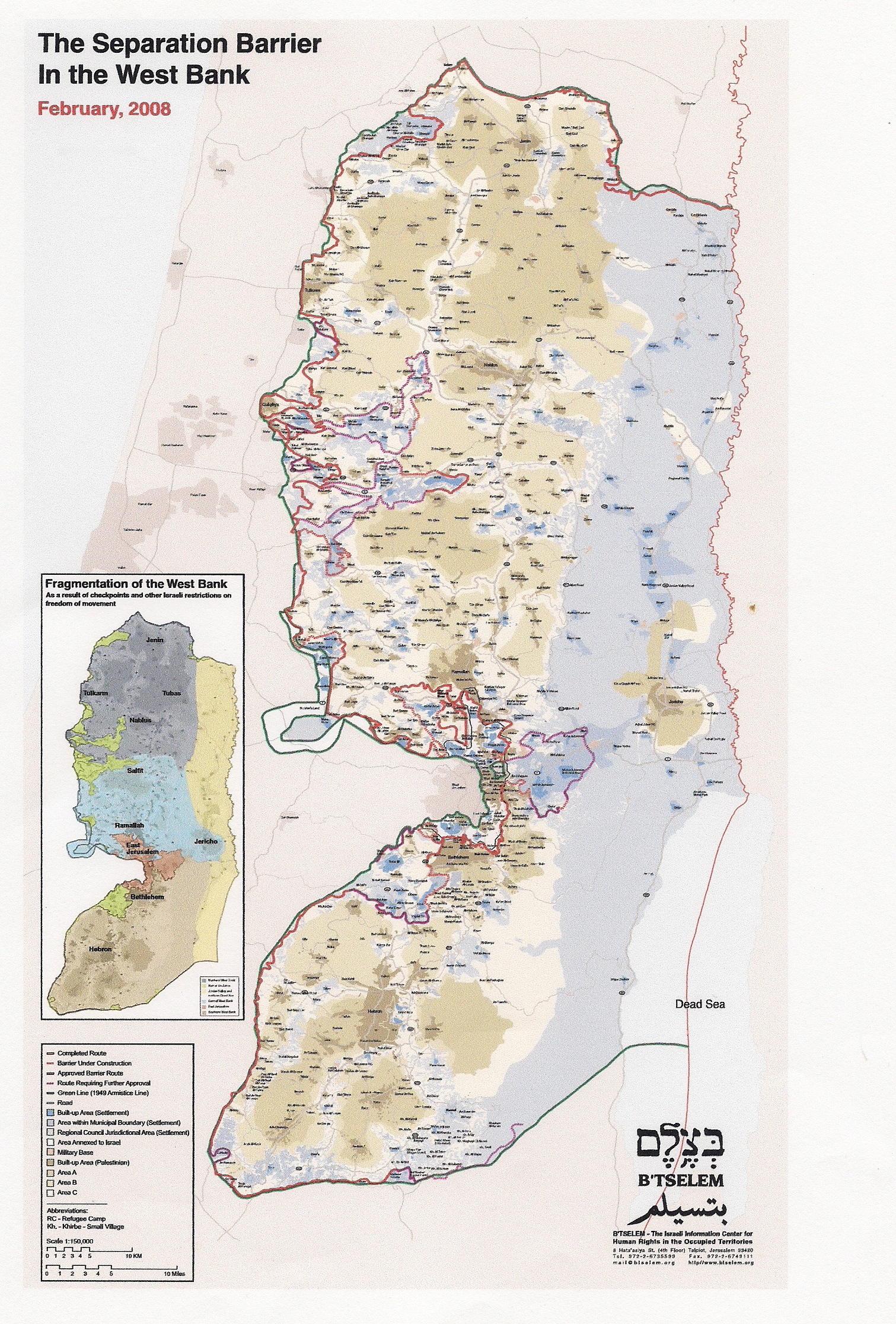Buoni e cattivi nel futuro scontro sociale in Italia: I buoni [terzo e ultimo capitolo]
di Eugenio Orso
I buoni nel futuro scontro sociale in Italia
Nell’individuazione degli amici e dei nemici sul piano sociale e politico, in questa sede provocatoriamente definiti “buoni” e “cattivi”, è necessario precisare che il Nemico Principale nella dimensione sociale è e rimane la Global class, in qualità di agente del capitalismo contemporaneo, ed in quella politica è rappresentato dalla cosiddetta liberaldemocrazia, che universalizza un suffragio impotente e impone l’istituto della rappresentanza.
La longa manu dei globalisti è penetrata nel nostro paese fin dagli inizi degli anni novanta e nel prossimo futuro cercherà di “stringere il pugno”, per impossessarsi delle ultime risorse, compromettendo la sopravvivenza di quel che rimane della grande industria nazionale, ancora totalmente in mani pubbliche [in quelle del tesoro, per quanto riguarda la Fincantieri], o comunque ancora legata al settore pubblico con partecipazioni e “golden share” [Eni, Enel, Finmeccanica].
Altri pesanti effetti negativi si produrranno in conseguenza dell’attacco finale al sistema pensionistico e ai diritti dei lavoratori, che da qualche tempo è in cantiere e si svilupperà probabilmente dopo la caduta di Berlusconi o dopo la sua capitolazione compromissoria.
Workfare di matrice anglosassone o forme simili e meno “costose” in sostituzione del welfare, “contratto leggero” a tutele ridotte in sostituzione del Ccnl, estensione dell’area della precarietà e pensioni ridotte all’osso, rappresenteranno altrettante minacce per la maggioranza della popolazione italiana, modificando completamente il quadro dei rapporti sociali e le prospettive future.
Gli apparati ideologico-mediatici ed accademici sono arrivati al punto di arruolare i demografi [come è accaduto con Antonio Golini, in Italia] per giustificare futuri innalzamenti dell’età pensionabile, da collegare all’innalzamento progressivo della vita media ed alla sconfitta della cosiddetta morte precoce.
Oppure si fa credere che il processo di deindustrializzazione innescato dalle delocalizzazioni, dal reengineering volto a ridurre gli occupati e dalle chiusure aziendali che hanno interessato l’Italia in questi ultimi dieci o quindici anni può essere fonte di competitività, e quindi un dato positivo, un’opportunità, sviluppando in sostituzione delle unità produttive decedute, delocalizzate o ridotte all’osso un terziario evoluto [ricerca, consulenza, servizi informatici] non certamente in grado di riassorbire la massa dei lavoratori espulsi dal manifatturiero, e non in grado di porre veramente rimedio alla “desertificazione” avanzante.
Rilevanti effetti negativi discenderanno dalla compressione dell’occupazione nel settore pubblico, dagli enti locali all’amministrazione centrale, dalla scuola alla sanità, ben oltre le millantate esigenze di “efficientamento” dello stesso.
Dopo anni di propaganda incessante “contro le inefficienze” della pubblica amministrazione e di attacchi mirati contro il pubblico impiego – I Nullafacenti, dell’ex comunista Pietro Ichino riconvertitosi in supporter dei macellai sociali, ne rappresentano una significativa testimonianza – ai quali non si è peraltro accompagnata un’adeguata riforma dello stesso, ma soltanto qualche misura punitiva nei confronti di gruppi di dipendenti dell’amministrazione [pensiamo ai “tornelli” di Brunetta o al più importante blocco delle retribuzioni e del turn-over], ridurre drasticamente i posti di lavoro nel settore pubblico potrà risultare più facile, suscitando minori opposizioni e resistenze in una compagine sociale prostrata dalla crisi, manipolata e flessibilizzata.
La violenza verbale di Ichino nei confronti dei dipendenti pubblici, descritti come portatori di un’odiosa rendita parassitaria nella sua opera più tristemente famosa [I Nullafacenti] e nelle interviste, nasconde il fine di tagliare le retribuzioni e soprattutto l’occupazione nel settore pubblico, rilasciando risorse per l’”iniziativa privata” ed in definitiva per la speculazione finanziaria, nel solco dei diktat globalisti.
Se si vuole che tutto funzioni come un’azienda – scuole ed ospedali compresi – tutto sarà sempre di più assoggettato alle regole stringenti ed alle espropriazioni del Libero Mercato, senza alcuna considerazione per gli aspetti sociali, per il diritto al lavoro e allo studio, per i diritti dei malati e per la stessa conservazione dei “beni pubblici puri”, i quali, per la loro stessa natura, sono estranei ai meccanismi di funzionamento del mercato.
Business della sanità e business dell’istruzione, frontiere irrinunciabili dell’esproprio e lucrosi mercati da sfruttare, nella più perfetta aderenza alle logiche di questo capitalismo si sostituiranno sempre più velocemente alla scuola ed alla sanità pubbliche che hanno garantito dal dopoguerra ad oggi scolarizzazione di massa e la mutua per tutti, così come al diritto al lavoro, all’istruzione e all’accesso ai medicinali ed alle cure mediche si sostituirà la posizione imposta a ciascuno, nell’ordine sociale, dal Mercato, e per i più deboli ed esposti ci sarà pur sempre il conforto della carità privata, del volontariato diffuso e della religione.
La riduzione ai minimi termini delle competenze e dell’azione dello stato, nonché della spesa pubblica nel suo complesso, sarà l’obbiettivo precipuo del prossimo governo nazionale – con o senza federalismo fiscale bossiano e “spesa standard” imposta alle regioni – poiché, come ha scritto il padre del peggior liberalismo contemporaneo, Milton Friedman, il ruolo del governo è quello di fare soltanto ciò che il Libero Mercato non può fare da sé, e L’esistenza di un governo, da questo punto di vista, è resa necessaria dal fatto che la libertà assoluta è impossibile. Per quanto seducente possa essere, sotto il profilo dottrinale, l’anarchia, essa, tuttavia, non è attuabile in un mondo di uomini imperfetti. [Efficienza economica e libertà, titolo originale Capitalism and Freedom, Vallecchi editore Firenze, 1967]
Dato che il Mercato sembra in grado di fare ogni cosa, o almeno così si fa credere, esattamente come faceva il Friedman che osservava la società americana negli anni cinquanta e sessanta – sostenendo, all’epoca, che il Mercato Libero era perfettamente in grado di occuparsi del servizio postale e di rompere finalmente uno storico monopolio dello stato – il ruolo del governo e delle amministrazioni pubbliche in generale, all’interno dell’organizzazione statuale, non può che ridursi all’essenziale, fissando “le regole del gioco” [oggi peraltro fissate dagli organi della mondializzazione, con ricadute negative, attraverso gli stati e i singoli governi, sulle popolazioni] e assicurando, di conseguenza, il più agevole scorrimento dei capitali finanziari in ogni dove.
I lineamenti anarchici di questo capitalismo senza ridistribuzione della ricchezza, con la pretesa della riduzione aziendalistica di ogni attività sociale, saranno evidenti anche nelle misure adottate dai futuri governi italiani, che faranno seguito al quarto esecutivo Berlusconi.
Nel tentativo di evitare l’insorgere di un’autentica protesta sociale in tutta la penisola, certe misure estreme d’esproprio e di de-emancipazione dei subalterni potranno essere più facilmente imposte da un governo compromissorio post-berlusconiano [con la partecipazione di futuristi, centristi, rutelliani, eccetera] o scopertamente anti-berlusconiano e di “centro-sinistra” [da Bersani a Vendola].
Allo bisogna potrebbe anche servire, pur se non rappresenta la soluzione migliore per gli interessi finanziario-globalisti, un nuovo esecutivo Berlusconi – che sarebbe il quinto e l’ultimo – in grado di reggere fino alla fine della sedicesima legislatura.
Si vedrà dopo la fatidica data del 14 di dicembre del 2010.
Un simile esecutivo non potrebbe che nascere da un compromesso segreto, che da un lato manterrebbe in carica l’attuale premier, interessato esclusivamente a non finire nel buco nero dei processi e dell’esproprio del suo impero privato, e dall’altro – autentico “patto leonino” imposto al conducador mediatico italiota, ormai indebolito dalle fronde interne, dagli scandali e dalla perdita di gradimento nei sondaggi – consentirebbe l’attivazione piena e l’accelerazione delle predette politiche economiche e sociali.
Gli attacchi contro la socialità, il lavoro, la giustizia distributiva e l’etica, bene impostati dagli ultimi esecutivi berlusconiano-leghisti, continueranno a spron battuto, estendendosi e approfondendosi dopo la caduta del “cavaliere festaiolo” o la sua capitolazione compromissoria, che gli consentirebbe di evitare i processi e di chiudere la legislatura alla bella età di settantasei anni, mantenendosi in sella fino al 2013.
Nel cupo contesto sociale, politico ed economico che si prospetta, sembra perciò ragionevole attendersi nuove e più estese tensioni sociali, l’insorgere di rischi di conflitti insanabili fra gruppi contrapposti, quanto ad interessi e condizioni materiali di vita, e fra questi ed il governo nazionale che sarà in carica.
La frantumazione dell’ordine sociale imposta da questo capitalismo, l’isolamento dei singoli destinati a diventare merce-lavoro e unità di consumo, oppure degli esclusi perché “inutili” nella Creazione del Valore finanziaria, azionaria e borsistica, hanno la funzione di blandire, ed anzi di prevenire, le reazioni sociali all’esproprio e al nuovo sfruttamento integrale dell’uomo, e perciò seminano l’inimicizia fra i gruppi sociali e i singoli, attivano una competizione esasperata di cui può beneficiare soltanto, per riprodursi all’infinito, l’impersonale ed anonimo meccanismo capitalistico.
Se l’individuazione dei nemici nel futuro scontro sociale risulta piuttosto agevole, a partire dal Nemico Principale contemporaneo, fino a giungere a quei gruppi sociali e politici interni nel precedente capitolo di questo saggio definiti “cattivi”, l’individuazione degli amici, qui definiti un po’ enfaticamente i “buoni”, non lo è altrettanto, poiché i veri amici si rivelano tali nel momento del bisogno, nel corso di un’emergenza o nello sviluppo di un processo rivoluzionario di liberazione costellato di lotte e di pericoli, e tuttavia si può ragionevolmente cercare, fin d’ora, di individuarli con sufficiente chiarezza.
Il processo di liberazione umana è un percorso lungo ed incerto, un percorso storico inconcluso che non può che iniziare con una rivoluzione, e svilupparsi nei secoli attraverso rivoluzioni successive, le quali rappresentano la condizione necessaria ma non sufficiente per consentire lo sviluppo futuro di tale processo, nel corso del quale, ed in particolare nei suoi momenti più critici e decisivi, si potranno riconoscere i veri “amici”.
Il quadro generale è certamente fosco, e lo è anche in Italia, in cui ai fattori esogeni di crisi, che investono con i loro effetti negativi buona parte dell’occidente, si sommano fattori endogeni preoccupanti ed altrettanto rilevanti – quali l’inadeguatezza di una politica che oscilla fra corruzione endemica e totale incompetenza, la forza crescente della criminalità organizzata, gli squilibri sociali approfonditisi di recente e quelli territoriali ormai storici, le spinte separatiste e dissolutive – ma esiste pur sempre una speranza che si riattivi il processo rivoluzionario di liberazione, e questa speranza risiede nella stessa natura umana, poiché L’uomo è per natura un essere sociale e comunitario o, più precisamente, un ente naturale generico. E’ dunque impossibile manipolarlo al punto tale da ridurlo ad una sorta di individuo puro ed astratto, un semplice supporto del sistema dell’individualismo proprietario capitalistico. [Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Controcorrente]
Il dubbio che può sorgere in questa analisi – dubbio che lo scrivente purtroppo non è in grado di sciogliere completamente – è se i gruppi amici, potenzialmente anticapitalisti, mostreranno compattezza nell’affrontare il nemico e lineamenti solidaristico-classisti, in una lotta finalizzata a riattivare processi emancipativi che da un paio di decenni il nuovo capitalismo ha inceppato, o se si tratterà, al contrario, di sporadiche battaglie di retroguardia delle vecchie classi sociali morenti, le quali resisteranno all’avanzare del nuovo ordine prima di estinguersi completamente.
O peggio ancora, non è facile prevedere se il futuro ci riserverà insurrezioni spontanee, scollegate le une dalle altre, suscitate da emergenze sanitarie, ecologiche e sociali, a macchia di leopardo sul territorio, e torbidi non più limitati alle esplosioni di rabbia delle sotto-classi urbane, che si accenderanno improvvisamente e rapidamente si spegneranno, lasciandosi alle spalle macerie e caos.
In questo ultimo caso, che è il più insidioso ed anche il più “illeggibile”, sia dal punto di vista politico sia da quello sociale, gli scenari tipicamente insurrezionali non potranno portare nulla di buono, in particolare per i subalterni.
Il futuro scontro sociale, a secondo della strada che prenderà e che oggi non è ancora prevedibile, si aprirà a diversi esiti possibili, che si possono riassumere, in sintesi, come segue:
1) Esiti positivi, emancipativi e trasformativi, che delineano l’innesco di un processo rivoluzionario, con la riemersione definitiva del problema sociale e l’attivazione della lotta di classe, esiti ai quali lo scrivente non crede [purtroppo] che si possano assegnare grandi probabilità, poiché la classe subalterna, nel nuovo ordine, è ancora in via di formazione e l’indispensabile elemento coscienziale non sembra ancora emergere con la dovuta chiarezza, come è apparso negli ultimi scioperi e nelle ultime manifestazioni dei lavoratori, nonché nella recente rivolta di studenti e precari della scuola contro la cosiddetta riforma Gelmini.
2) Esiti sostanzialmente negativi, in conseguenza di pure battaglie di retroguardia delle vecchie classi sociali morenti, o lotte di natura prettamente sindacale e rivendicazionista, o peggio ancora di natura corporativa e “lobbistica”, destinate a spegnersi in breve tempo senza lasciare troppe tracce nella società, oppure ad arrestarsi bruscamente davanti ad una più decisa repressione sistemica. Se così sarà, il potere vigente coglierà l’occasione per lanciare una nuova offensiva propagandistica flessibilizzante, e quindi per un suo ulteriore rafforzamento. L’incognita del separatismo regionalista, di matrice leghista ma con possibilità di diffusione anche nel sud della penisola, permarrebbe immutata.
3) Esiti dissolutivi, che la repressione delle insurrezioni e dei torbidi potrà non riuscire a contenere, con il rischio del collasso delle istituzioni e la diffusione di violenze incontrollate. Ne trarrebbero qualche vantaggio, nel breve, in primo luogo lo”stato di mafia”, che potrebbe estendere significativamente il controllo del territorio a sud, e forse le bande leghiste e separatiste del nord, che potrebbero spingersi fino a proclamare l’indipendenza di parti del territorio settentrionale. Affinché simili scenari si concretizzino, oltre a forti spinte dissolutive endogene dovute ad un precipitare della situazione economica, sociale e politica interna già oggi in bilico, dovrebbero verificarsi eventi esogeni di una certa gravità, di natura finanziaria, valutaria, ecologica e/o militare. Tuttavia, è probabile che in simili circostanze interverrano d’autorità gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea, se necessario servendosi dello strumento NATO, per porre il paese sotto la loro diretta “tutela”.
I primi due gruppi sociali amici, che dovrebbero porsi alla guida della protesta riattivando il motore della lotta di classe da troppo tempo ingrippato, sono costituiti dagli operai, abbandonati da quasi tutti i sindacati [con l’eccezione lodevole della Fiom di Rinaldini, Landini e Cremaschi] e da tutti i partiti sistemici, compresa quella sinistra “radicale” che è stata espulsa dal parlamento nel 2008, e da quella parte dei ceti medi in via di rapida ri-plebeizzazione che esprime il lavoro dipendente intellettuale, tecnico, specialistico, impiegatizio, soggetta ai contratti di precarietà ed alle espulsioni dal ciclo produttivo quanto gli operai, con i quali ormai condivide non pochi interessi e un destino comune.
Questa ultima componente è stata fortemente penalizzata negli ultimi anni assieme al lavoro operaio qualificato, oltre che dai processi di globalizzazione economica che ne hanno seriamente compromesso i redditi e lo status, dalle politiche dei governi berlusconiano-leghisti e da quelle del breve esecutivo prodiano.
Si tratta dei gruppi sui quali si fa e si farà ricadere il peso maggiore della [presumibilmente] lunga crisi economica che ha investito l’economia reale dalla seconda metà del 2008, con l’onda d’urto dei cali di produzione, dell’aumento della disoccupazione e della contrazione dei consumi.
La crisi si è riverberata su un’economia già stagnante, in un paese con i salari fra i più bassi dell’Europa occidentale, e non potrà non avere effetti di lungo periodo sul piano sociale, destabilizzandolo, perché gli ammortizzatori, abbondantemente usati a partire dalla cassa integrazione, non potranno “tamponare le falle” indefinitamente non essendo sostenibili nell’arco dei prossimi otto o dieci anni, né dalle imprese né tanto meno dai lavoratori [fra i quali molti cassaintegrati a zero ore], decine e decine di milioni di ore di CIG.
Considerando operai, impiegati e ceti medi legati al lavoro dipendente, pubblico e privato, si riesce ad abbracciare la grande maggioranza della popolazione attiva in questo paese [circa i tre quarti della stessa], quella che nel bene e nel male veramente “regge la baracca”, consentendo la bella vita da sub-dominanti a politici, impresari, speculatori, evasori fiscali e criminali, organizzati e non.
Il fatto che questi gruppi, fondamentali per la produzione delle basi materiali della vita associata, non abbiano oggi dei veri rappresentanti politici – pur essendo chiamati, periodicamente, a partecipare al rito del voto liberaldemocratico per legittimare una falsa rappresentanza – e nei fatti non partecipano alle decisioni strategiche che li riguardano, che devono soltanto subire, avrebbe dovuto rendere in breve la situazione esplosiva, ma lunghi anni di manipolazione, di dominazione simbolica, di flessibilizzazione e precarizzazione, oltre a svalutare economicamente e culturalmente il loro lavoro, hanno contribuito a dividere questi gruppi, a disperderli per evitare adunate “sediziose” e quindi pericolose per il potere, fiaccandone la resistenza, ed almeno in apparenza, compromettendone la combattività.
Ogni atto compiuto dai lavoratori dipendenti, anche se blando come il lancio di uova o di insulti, che possa soltanto lontanamente ricordare la lotta di classe novecentesca, viene oggi preso a pretesto dai cialtroni del circo mediatico e dai vili intellettuali subalterni per colpevolizzare in modo disgustoso le vittime, fino ad arrivare alle accuse di squadrismo e di terrorismo.
La lotta di classe deve perciò essere bandita anche dai ricordi, o selvaggiamente criminalizzata se riappare come uno spettro inquietante, perché la dominazione della Global class filtrata attraverso i poteri locali sub-dominanti deve essere assoluta, ed il sistema liberaldemocratico deve fornire il necessario supporto agli interessi e alle strategie dei dominanti.
Liberalizzazioni, privatizzazioni, delocalizzazioni e lavoro-merce rispecchiano i suddetti interessi nella nostra società, e quindi non devono incontrare indebite resistenze.
Colpendo il lavoro ed i lavoratori in questo modo, si vuole “fiaccare la resistenza” nella società, rendendola malleabile, controllabile e pienamente gestibile dall’alto, e perciò vi è una parte di verità in quanto è riportato nelle “Considerazioni generali” del 44esimo Rapporto Censis, in cui l’intera società italiana è descritta come “appiattita” con i riferimenti più alti soppiantati dalla delusione per gli esiti del primato del mercato, della verticalizzazione e personalizzazione del potere, del decisionismo di chi governa, ma quello che per il Censis è il declino della soggettività, prostrata da processi che hanno radici e motori fuori della realtà italiana, altro non è che l’esito del processo di flessibilizzazione di massa per la costruzione sociale dell’uomo precario.
Il processo manipolatorio per la diffusione della precarietà ha colpito tutto il corpo sociale, ma in primo luogo ha interessato i lavoratori, essenzialmente per impedire che determinazione, coesione e solidarietà potessero rinvigorirne la protesta.
Lo stesso Censis ci avverte, nel medesimo Rapporto, che nell’ultimo decennio [dal 1999 al 2009], il lavoro dipendente ha mostrato una forte crescita, superiore ai due milioni di unità, mentre il cosiddetto lavoro autonomo si è ridotto complessivamente di ben duecentomila unità, incidendo sul totale degli occupati per meno di un quarto, a dimostrazione che nei fatti lo slogan liberista “diventa imprenditore di te stesso” attrae sempre di meno [vista la “delusione” che ha comportato il Libero Mercato primeggiante], ma anche perché, per poter iniziare un’attività imprenditoriale, è preferibile avere buoni mezzi alle spalle e “il culo coperto”.
In sostanza, la minor propensione di giovani e meno giovani a diventare imprenditori, professionisti e consulenti, od anche soltanto bottegai, può essere imputata alla necessità di possedere, per incamminarsi su questi percorsi, i mezzi patrimoniali e finanziari necessari, ed in effetti, in una società in cui la coperta delle risorse è sempre più corta e gli squilibri economici fra i gruppi sociali sempre più grandi, sono sempre di meno coloro che anelano a diventare “imprenditori di sé stessi”, e soprattutto, coloro che hanno concretamente le risorse per poterlo fare.
L’alleanza fra operai e ceti medi riplebeizzati è fondamentale, a detta dello scrivente, affinché la lotta possa avere qualche speranza di successo, ma questa alleanza, e la comunanza di interessi che la renderà possibile, costituirà la migliore prova che l’ordine sociale non è più quello che ha caratterizzato la seconda metà del Novecento, che tutto è mutato, e che una nuova classe subalterna, la Pauper class, sta per affacciarsi all’orizzonte della storia.
Se le vecchie organizzazioni dei lavoratori si sono trasformate in agenzie di supporto del nuovo capitalismo ed i partiti di massa sono ormai definitivamente scomparsi, sostituiti da vergognosi ed effimeri cartelli elettorali privi di anima e di storia [PdL, Pd, UDC], oppure da congreghe di separatisti ed evasori fiscali che inventano nuove patrie [Lega Nord], i due gruppi sociali amici dovranno ricostruire integralmente le loro organizzazioni, senza cadere nella trappola liberaldemocratica della “novità”, del nuovo prodotto politico di rapido consumo, della formazione nuova di zecca che millanta di rappresentare i non rappresentati e che finge un’improbabile alternativa, per poi confluire in maggioranze di governo incaricate dagli interessi dominati di massacrare il lavoro e la socialità.
Un lavoro dipendente sempre più povero e compresso, privo di rappresentanza politica e di tutele sociali rientra perfettamente nei disegni dei dominanti, per un futuro interamente nelle loro mani, ed allora le retribuzioni devono essere sempre più strettamente legate al solo tempo di lavoro ed alla trappola della “produttività individuale”, che rappresenta una giustificazione di matrice economicistica per ridurle progressivamente.
Si vuole, in buona sostanza, ridurre alla completa variabilità l’intero salario, precarizzandolo integralmente insieme al lavoratore.
Per legare le retribuzioni, e quindi lo stesso costo del lavoro da comprimere all’infinito, al solo tempo di lavoro, la via dei contratti di precarietà e del lavoro a termine sembra la migliore, sicuramente la più vantaggiosa astraendo completamente da considerazioni etiche e dalle sofferenze imposte all’uomo, ed è per questo che dagli anni novanta ad oggi è nato un nuovo gruppo sociale, le cui file si sono gonfiate fino ad accogliere alcuni milioni di soggetti, non necessariamente tutti giovani o giovanissimi.
Il gruppo dei precari e dei falsi lavoratori autonomi, cioè i parasubordinati, è da considerarsi un gruppo potenzialmente “amico”, e visto che il massimo della flessibilità del lavoro si realizza con il “nero”, la più piena e totale informalità che non prevede buste paga, contributi, versamenti d’imposta, ferie, permessi e maturazione della pensione, in questo gruppo possiamo comprendere anche molti lavoratori “in nero”.
L’obbiettivo del nuovo capitalismo, attraverso la dominazione del Libero Mercato – sia dal punto di vista del razionamento delle risorse e dell’esclusione dai rapporti sociali di produzione sia da quello ideologico –, è di ridurre integralmente le società ad una mera rete di rapporti commerciali, fondata sullo scambio mercantile e ancor di più sulla Creazione del Valore, e di far nascere e morire precari gli uomini come inevitabile conseguenza.
Se la precarietà c’è sempre stata nel corso della storia umana, ma ha riguardato una piccola minoranza, questo capitalismo l’ha approfondita ed estesa, al punto che tende a diventare una condizione esistenziale sempre più diffusa, anzi, la condizione esistenziale che caratterizza quest’epoca storica, potenzialmente estensibile a tutta l’umanità, e in ciò risiede l’esito, totalmente anti-umano ed anti-etico, profondamente criminale, del capitalismo liberista contemporaneo.
Perciò, criminali sono i pubblicisti e gli “ingegneri” della precarietà, pagati lautamente da questo sistema ed incensati anche dopo la morte, a partire da Marco Biagi.
La leggenda che la precarietà è stata introdotta in Italia negli anni novanta [1997, la famigerata legge Treu] per favorire “l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”, e che quindi avrebbe rappresentato una condizione di minorità temporanea, un male necessario ma passeggero per poter accedere al posto fisso, si è rivelata in breve tempo per quello che è, un’atroce menzogna diffusa ad arte dai media, dagli accademici [con la lodevole eccezione di Luciano Gallino, il più grande sociologo italiano vivente] e dai politici di sistema, tutti o quasi concordi nel supportare questa decisiva campagna contro i lavoratori, da sinistra a destra senza distinzioni.
I lavoratori “usa e getta” subiscono più di tutti gli altri le asprezze dello spietato modello liberalcapitalistico finanziarizzato e transgenetico del terzo millennio, e per tale motivo potrebbero rappresentare un’autentica forza rivoluzionaria – incontenibile in quelle stesse dinamiche capitalistiche che l’hanno generata – nel futuro scontro sociale in Italia.
Precari contrattualizzati, parasubordinati spacciati per lavoratori autonomi o “consulenti” e lavoratori in nero, oggi non coprono soltanto le esigenze di una produzione tradizionale, offrendo lavoro dequalificato, meramente esecutivo, a basso contenuto tecnologico e a bassa scolarità, ma offrono sempre più spesso un lavoro intellettuale, ad alto contenuto scientifico e tecnologico, in settori cosiddetti di nicchia o nella ricerca applicata.
Ma la condizione economica ed esistenziale del professore universitario precario o del ricercatore a termine, che deve contarsi in tasca i soldi per il biglietto del treno quando deve partecipare ad un seminario o ad una conferenza in una città lontana, nella sostanza non è diversa da quella del lavoratore interinale impiegato da una falsa cooperativa nelle pulizie industriali, e la situazione economica del primo tenderà sempre di più ad approssimare quella del secondo.
Se sarà possibile unire il lavoro operaio, orfano della classe storica antagonista novecentesca “operaia, salariata e proletaria”, i ceti medi riplebeizzati che esprimono il lavoro intellettuale ed impiegatizio stabilizzato ai precari, ai parasubordinati e a molti lavoratori “in nero”, si produrrà una forza sociale antagonista che difficilmente potrà essere arginata dall’applicazione dei sistemi repressivi e disciplinari del potere vigente, e questa dovrebbe rappresentare una mera evidenza per tutti, perché è proprio nella svalutazione e nella compressione capitalistica del lavoro, portate alle estreme conseguenze, che matureranno le future istanze rivoluzionare ed emancipatrici.
La distanza fra gli stabilizzati ed i precari tenderà rapidamente a ridursi, poiché se operai, impiegati, tecnici non soffrono la precarietà occupazionale in quanto hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, molti fra loro non sfuggono alla precarietà nelle prestazioni, che rappresenta un grimaldello, nella persistenza dei vecchi contratti di lavoro, per scardinare progressivamente le tutele e i diritti.
E’ ben vero che fino ad ora si è cercato, con un certo successo, di mettere i lavoratori stabili e quelli precari l’uno contro l’altro, in un divide et impera contemporaneo che tende a preservare le strutture di potere e i meccanismi riproduttivi capitalistici, ma è anche probabile [e chi scrive ne è sinceramente convinto] che esiste un limite fisico e psicologico all’esproprio di risorse e di diritti, alla compressione materiale del lavoro ed al peggioramento complessivo delle condizioni di vita dei subordinati, valicato il quale ci si deve attendere una reazione generalizzata, che potrà portare all’unione di questi gruppi sociali, ad una loro stretta alleanza quali membri di un’unica, nuova classe sociale: la classe povera del terzo millennio.
Il penultimo grande gruppo sociale iscrivibile fra i “buoni” è un gruppo di recente formazione, che lo scrivente ha deciso di autonomizzare in considerazione delle sue caratteristiche e delle sue specificità, anche se i soggetti che lo compongono esprimono il lavoro operaio, quello precario, il lavoro informale, o addirittura il lavoro schiavizzato in certe parti della penisola [Rosarno e la piana di Gioia Tauro, Puglia, provincia di Latina e Agro Pontino, eccetera], ed in misura minore esprimono il lavoro intellettuale e impiegatizio.
Si tratta dei lavoratori immigrati, che in questo paese sono circa un milione e novecentomila – secondo i dati ufficiali, con la necessaria avvertenza che il sommerso e il lavoro schiavo sono difficili da quantificare – e per oltre i due terzi del totale provengono da paesi extracomunitari, in molti casi da regioni del pianeta profondamente diverse dalla nostra.
A questi lavoratori, considerati indispensabili per mandare avanti le attività produttive ed i servizi nel paese più vecchio del mondo, quale è l’Italia insieme al Giappone, e richiesti dagli stessi industriali che da tempo hanno puntato sul lavoro a basso costo [se non “a sconto”], stanno imprimendo al paese una vera e propria svolta demografica [di suo, l’Italia sarebbe in una situazione di pesante calo delle nascite], e nel tempo sono usciti progressivamente dallo stereotipo che gli assegna quei lavori “che gli italiani non vogliono più fare”, perché sono presenti ormai in numerosi settori di attività, ed in una minoranza dei casi esprimono il lavoro qualificato, scientifico [ad esempio i medici] e creativo.
Non si tratta esclusivamente delle badanti filippine o rumene che curano gli innumerevoli anziani non autosufficienti sparsi in tutto il paese, poiché gli apporti del lavoro immigrato interessano tutti i settori produttivi e sono diventati fondamentali per la produzione delle basi materiali della vita associata in Italia.
Certo, in generale gli immigrati sono quelli che hanno sopportato e sopportano le peggiori condizioni lavorative ed i peggiori abusi da parte di impresari senza scrupoli, pur con delle differenze fra regione e regione [in Calabria ed anche in Veneto, ad esempio, la loro situazione è complessivamente peggiore di quella che vivono nel Friuli Venezia Giulia], e sono più colpiti degli italiani, in proporzione, dalla recente ondata di disoccupazione, per questi lavoratori superiore al dieci per cento nelle stesse stime ufficiali.
Altra considerazione importante – lasciando perdere le diffamanti accuse di matrice leghistico-bossiana che presentano gli immigrati come un gruppo interamente costituito da delinquenti abituali e rapinatori, indegne persino di essere considerate – è che non si tratta affatto di un gruppo omogeneo, dal punto di vista delle origini culturali, religiose, etniche, il quale sconta anch’esso il divide et impera capitalistico, nel senso che si utilizza per abbattere il costo del lavoro e per un ennesimo ricatto capitalistico [“o tu lavori a condizioni peggiori di prima o c’è sempre un immigrato disposto ad accettarle”], ponendolo artatamente in competizione con i lavoratori autoctoni.
Tuttavia, pur essendo il lavoro immigrato, contrattualizzato o informale che sia, espressione di una miriade di etnie, di religioni e di culture diverse, in certi casi portatrici di contenziosi storici l’una nei confronti dell’altra [i serbi non amano gli albanesi, e viceversa, i mussulmani del Kashmir non amano gli indù, eccetera], pur trovandosi in competizione reciproca e soprattutto in competizione con gli autoctoni nell’universo del lavoro astratto capitalistico, questo stesso lavoro, la sua sostanza, la comune condizione di sfruttamento e de-emacipazione che oggi si riafferma con prepotenza nei concreti rapporti di produzione, potranno costituire l’elemento unificante, il collante più duraturo, che vale ben di più di una generica e formale integrazione nel paese che li ospita.
Infatti, una nuova coscienza di classe estesa ai lavoratori immigrati, è il più potente veicolo per l’integrazione e il cambiamento.
L’ultimo gruppo potenzialmente amico, in questa breve panoramica che riguarda la strutturazione sociale in rapporto ai futuri, possibili conflitti nella società italiana, è rappresentato dai disoccupati, dagli inoccupati, da coloro che sono senza lavoro e resteranno in questa condizione per lungo tempo.
Nell’iscrivere disoccupati, inoccupati ed in generale i senza lavoro fra i “buoni” è necessario adottare alcune cautele, avanzare qualche legittimo dubbio ed operare qualche distinguo, poiché in Italia dimora un esercito di giovani [dai 15 ai 34 anni] i quali non studiano, non hanno un posto di lavoro né lo cercano, un esercito di dimensioni superiori a quello dei lavoratori immigrati, forte di oltre due milioni e duecentomila unità, se dobbiamo credere alle analisi del Censis, del suo direttore Giuseppe Roma e del suo presidente, il noto sociologo Giuseppe De Rita.
L’inerzia, l’assenza di stimoli, la stessa indifferenza per il proprio stesso futuro che questi giovani inoccupati in apparenza esprimono, si inserisce perfettamente nel discorso di Giuseppe De Rita sull’”appiattimento” generale della società italiana, ma, a ben vedere, è un riflesso dell’azione devastante sul piano sociale del Libero Mercato, inteso quale supremo sistema di razionamento e di esclusione, che condanna un numero sempre più grande di persone all’esclusione a vita dal lavoro e dai rapporti di produzione [vedi, a tale proposito, Nuovi signori e nuovi sudditi. Ipotesi sulla struttura di classe del capitalismo contemporaneo. C. Preve – E. Orso].
Ma il discorso sulla rinuncia generazionale al lavoro e allo studio non si esaurisce con il richiamo al funzionamento dei meccanismi di Mercato, e deve essere ulteriormente approfondito.
Se qualche ipocrita ben retribuito e spacciato per grande sociologo [neppure serve fare il nome] tempo fa ha scritto sulla prima pagina del Corriere che questo inquietante fenomeno, parte del più ampio fenomeno della disoccupazione e dell’esclusione, è frutto della pigrizia, dell’indolenza dei singoli, della loro propensione a ricevere i soldi a casa senza lavorare [Soldi e successo senza fatica. Così il pigro si gode la vita, Il Corriere della sera, 7 settembre 2009], porgendo una spiegazione depistante che come spesso accade tende a colpevolizzare la vittima, dovrebbe esser chiaro che dietro questa scelta, maturata in giovane età, si nasconde quello che per molti ragazzi è un deciso rifiuto, in molti casi non consapevole, delle dinamiche capitalistiche nel loro complesso.
E’ vero che questo rifiuto origina in primo luogo dal funzionamento del Mercato, e dalla sua sempre più frequente tendenza ad escludere, a scoraggiare, ad allontanare dal lavoro, piuttosto che ad includere creando il profilo del produttore-consumatore, come accadeva nella seconda metà del Novecento, ma non può essere certo tutto qui, ed ancor meno si tratta del vecchio “effetto del lavoratore scoraggiato” che smetteva di cercare lavoro, una volta constatata l’inutilità dei suoi sforzi, come accadeva in altre età del capitalismo.
Il rifiuto profondo, che molti giovani scivolati nella condizione “Not Employed in Education and Training” esprimono, per qualche verso sostituisce l’esplicito ribellismo giovanile sessantottesco, e se gli studenti sessantottini volevano cambiare il mondo, gli attuali giovani inoccupati “per scelta” seguendo questa via – che forse è l’unica oggi praticabile se non si vuole lanciare le molotov contro i blindati o premere il grilletto di una P38 – mostrano di voler uscire dal mondo, simboleggiato dalla società capitalistica di mercato onninvasiva, e così predispongono l’”esodo”.
Un “esodo” silenzioso che forse non li porterà da nessuna parte, se non interverranno eventi scioccanti che potranno rimettere la storia in movimento perturbando l’orizzonte della riproduzione capitalistica.
Oggi, in luogo del vecchio profilo del produttore-consumatore sembra prevalere il profilo del precarizzato-escluso, ma questi giovani, senza attendere che li escluda una sentenza del Mercato, scelgono l'auto-esclusione e se ne vanno, sbattendo la porta dietro di sé.
I giovani "NEET" intendono forse, pur non consapevoli di questo, togliere l’acqua al pesce capitalistico, a poco a poco, per farlo morire boccheggiando?
Oppure è soltanto una forma silenziosa di ribellismo giovanile, destinata a rientrare con la prossima generazione, che non avrà alcun esito politico e sociale determinante?
Chi scrive non sa dare una chiara risposta a queste domande, purtroppo, ma per gli scopi che si prefigge il presente saggio, è sufficiente far rilevare che questo ultimo gruppo di “buoni” è molto composito, e pone non pochi problemi proprio per la sua “varietà”, poiché accanto ai cinquantenni disoccupati che hanno perso un posto di lavoro stabile e ne cercano senza esito un altro, vi sono giovani inoccupati per scelta “silenziosamente ribellistica” e parzialmente inconsapevole, oppure, in una minoranza dei casi, sfaccendati che tali sarebbero anche in un’altra epoca storica.
D’altra parte, il concetto di disoccupazione è nato all’interno del mondo capitalistico, in cui è stato costituito e sempre mantenuto con funzioni ricattatorie [anche ai tempi del pieno impiego keynesiano, del welfare e dell’inclusione moderatamente emancipatrice] quel ”esercito industriale di riserva” che nel terzo millennio rischia di assumere dimensioni pletoriche, diventando più propriamente l’”esercito degli esclusi”, ma gli sfaccendati che talora non sfuggono alle rilevazioni statistiche sono sempre esistiti, come minoranza bizzarra e tollerata, fin dal mondo antico ed anche prima di esso.
Eppure la pubblicistica liberale e liberista, al servizio del capitale a tempo pieno, ci racconta la storiella dello sfaccendato, del perdigiorno, del pigro, del “furbo” che attende il sussidio di disoccupazione e che preferisce dormire fino a tardi la mattina, o del giovane che vive comodamente in famiglia con i soldi del padre, per nascondere la vera origine del problema della disoccupazione e dell’esclusione, rigirando l’accusa che potrebbe essere mossa a questo capitalismo contro le sue vittime prestinate.
In Italia si fa molto affidamento sulle “reti familiari e amicali”, storicamente molto sviluppate in tutta la penisola, per sostentare il più a lungo possibile disoccupati, inoccupati, e vari altri soggetti non concretamente attivi.
In particolare, si tende sempre di più a scaricare questo problema assieme a tanti altri [anziani non autosufficienti, invalidi], a mano a mano che il welfare rifluisce, sulla famiglia, sulle reti di rapporti personali e sulla comunità.
Peccato che queste reti siano state seriamente indebolite dalla crisi, dal giugno del 2008 ad oggi, e se la crisi continuerà per buona parte del prossimo decennio [com’è molto probabile, anzi, com’è praticamente certo] queste reti salvifiche rischieranno di collassare.
Le pensioni del padre e della madre, anche loro ridotte all’osso, potranno non bastare per poter mangiare in tre come prima, dando sollievo al figlio inoccupato, ed è così che si registrano cali nei consumi e nella stessa spesa alimentare delle famiglie, con circa un quarto delle famiglie italiane che già da tempo è in forte difficoltà e deve rinunciare a prodotti e a servizi essenziali… altro che solide “reti familiari e amicali” di sostegno!
I disoccupati di lungo periodo, in un paese in cui esiste l’ammortizzatore sociale della cassa integrazione per gli occupati con contratti “regolari”, ma non esiste un degno sussidio di disoccupazione o un’auspicabile salario di cittadinanza garantito a tutti, sono fra gli attivi quelli che vivono più di ogni altro l’esclusione capitalistica.
I disoccupati sono prigionieri che il Nemico Principale utilizza come monito per piegare le resistenze dei subalterni, per scongiurare rivendicazioni di retribuzioni più alte e di nuovi diritti, e sempre più spesso per ridurre le retribuzioni e cancellare i diritti.
Il Nemico utilizza disoccupazione ed esclusione come armi nella “sua” lotta di classe.
Tralasciando gli sfaccendati per vocazione o coloro che sono dediti ad attività criminali e perciò risultano disoccupati, i molti milioni di lavoratori espulsi dal processo produttivo, di attivi inoccupati e di giovani “NEET” – l’esercito degli esclusi che ha sostituito il vecchio esercito industriale di riserva – potrebbero costituire un altro significativo gruppo nel futuro scontro sociale in Italia, non soltanto dal punto di vista numerico, e un alleato importante per gli operai, i ceti medi riplebeizzati, i precari, i parasubordinati, i lavoratori informali ed i lavoratori immigrati.
In conclusione di questo capitolo, una menzione particolare va riservata agli studenti, delle scuole medie superiori e delle università, che hanno iniziato una lotta per il diritto allo studio e per la difesa della scuola pubblica contro l’orrenda riforma Gelmini, con la quale si vuole svendere il patrimonio delle istituzioni universitarie e scolastiche e tagliare drasticamente i costi dell’istruzione.
Gli studenti non accettano il dominio della logica aziendalistica ed economicista, e tanto meno quello delle imprese private, che penerebbero nella scuola pubblica non tanto per armonizzare i programmi di studio con le fatidiche esigenze “del mondo della produzione”, ma con secondi fini ed a scopo di lucro.
Questa battaglia è cruciale quanto quella per la difesa del diritto ad un lavoro decentemente retribuito e dignitoso, o per l’accesso universale ai medicinali e per la difesa dell’acqua pubblica.
Gli studenti non rappresentano certo uno specifico gruppo sociale, e quindi nel presente saggio sono stati un po’ trascurati, ma la loro lotta, vigliaccamente silenziata da molti media sistemici e dalle numerose televisioni sotto il controllo dei mercenari berluscones, ha in questo momento un grande significato simbolico, e perciò chi scrive spera che questa lotta non si arresti ma riprenda con un certo vigore, incontrando sempre maggiori adesioni nel mondo della scuola ed anche al di fuori di esso.
Una domanda è bene porsi, prima di chiudere definitivamente: da quale parte staranno gli studenti che oggi occupano e manifestano quando inizierà il vero scontro politico e sociale in questo paese?
La risposta è scontata.