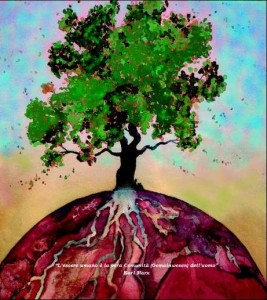L’indifferentismo morale e la cultura dell’individualismo di massa
Intervista con il Prof. Costanzo Preve a cura di Luigi Tedeschi
1. Il degrado politico – culturale delle classi dirigenti della politica sia italiana che
europea, riflette il venir meno nell’ambito della società occidentale di valori di
carattere etico riconosciuti, su cui cioè, possa fondarsi un giudizio morale che
presieda alle scelte politiche dei popoli chiamati alle urne. L’indifferentismo morale
collettivo, è ahimé constatabile in questi giorni dinanzi alla aggressione armata
dell’Occidente nei confronti della Libia, stato sovrano riconosciuto dall’ONU,
bombardato in base ad una risoluzione delle Nazioni Unite voluta da Obama. Gli
USA hanno decretato la fine di Gheddafi senza che tale risoluzione, emessa in
spregio del diritto internazionale, fosse condannata dal sentire comune dei popoli,
come se tali avvenimenti, in cui l’Italia è coinvolta in prima persona, si verificassero
in altri mondi ed altri tempi. Non suscita certo entusiasmo l’aggressività armata
della Nato, né suscita molta indignazione la condanna dei presunti “crimini contro
l’umanità” attribuita a Gheddafi, ma la politica imperialista americana e lo stato di
soggezione dei paesi vassalli europei sono fatti che vengono accettati acriticamente
come uno stato di fatto che prescinde dalla volontà dei popoli, ormai estraniati dalle
scelte politiche delle classi dirigenti. Tutti ricordano i milioni di manifestanti scesi
nelle piazze di tutta l’Europa nel 2003 per condannare la guerra di Bush contro
l’Iraq, ma quei sentimenti protesta e di condanna contro l’imperialismo armato degli
USA sembrano scomparsi. In realtà l’esaurirsi di tale dissenso è dovuto proprio al
suo contenuto ideologico “pacifista”. Si condannava l’America, in quanto
aggressore armato dell’Iraq, ma nel contempo si condannavano i “crimini contro
l’umanità” di Saddam e si invocava la pace. Questo linguaggio pacifista adattato ai
tempi odierni assume questa chiave di lettura: si deve condannare l’intervento
armato della Nato, ma Gheddafi, in quanto criminale internazionale deve essere
destituito e processato, ma il tutto deve avvenire per via pacifica. E’ evidente che in
tal modo la protesta sposerebbe nella sostanza la strategia americana (tra l’altro
tendente al disimpegno militare diretto), ma contesterebbe solo le modalità
esecutive. Ipocritamente non si effettuano scelte di campo: nessuno sta con
Obama, nessuno con Gheddafi, tutti siamo per la pace. La protesta pacifista fallì nel
2003, perché non si effettuarono chiare scelte di campo. Occorre infatti schierarsi
sia con Gheddafi che con Saddam, ma non con le loro pur discutibili persone, ma
come rappresentanti legittimi di stati sovrani. La scelta è la seguente: o si prendono
le parti dell’imperialismo armato occidentale, oppure ci si batte per la sovranità
degli stati ed il diritto internazionale, tertium non datur. L’indifferentismo morale
collettivo attuale è la conseguenza della morale della non scelta, dell’assenza di una
causa con obiettivi politici concreti da conseguire.
Applicato direttamente e senza mediazione ai fatti storici, politici e sociali, il moralismo non
è solo la morte della politica, ma è anche e soprattutto la morte della stessa morale. La
morale, infatti, è sempre la specificazione problematica all’interno della singola coscienza
individuale dell’etica, e senza un’etica comunitaria sensata la stessa morale si agita in un
vuoto pneumatico senza fondamenti, consegnata al più puro arbitrio (cfr. Costanzo Preve,
Storia dell’Etica, Petite Plaisance, Pistoia 2007). Ma la stessa etica trova il suo
fondamento in una ontologia dell’essere sociale, che a sua volta presuppone un’analisi
“materiale” dell’economia e della geopolitica internazionale. Il moralismo non sa che
farsene di tutto questo, perchè è il regno dell’arbitrio soggettivo spacciato per riferimento a
presunti “eterni valori dell’Uomo”.
L’indifferentismo morale cui tu fai giustamente riferimento, e che correttamente attribuisci
al degrado delle classi dirigenti italiane ed europee (senza mai dimenticare che la testa del
serpente non sta a Roma o a Parigi, ma a Washington e nella pretesa messianica di
uniformare il mondo intero al solo criterio di giudizio protestante e sionista), è però il
prodotto dialettico perverso di una ipertrofia moralistica ipocrita, e non nasce dal nulla, ma
deve essere diagnosticato correttamente, se vogliamo guarirne ed uscirne fuori. La
recente guerra USA-NATO contro la Libia di Gheddafi, cui fai riferimento (scrivo nel giorno
di Pasqua 2011, e quindi non posso conoscerne ancora gli esiti, che immagino comunque
tragici per il popolo libico e per il diritto internazionale) ne è un esempio, ed è bene
parlarne direttamente. Non è certamente la prima volta che assistiamo a questo copione di
manipolazione organizzata e di criminalità mediatica. Dopo la dissoluzione del comunismo
storico novecentesco, talvolta impropriamente battezzato come “dittatura totalitaria” o
come “socialismo reale”, il caso-Libia è solo la terza volta. La prima volta è stata la
Jugoslavia (1999), e la seconda volta l’Irak (2003). In tutti e tre questi casi la sfacciata
violazione del diritto internazionale è stata ipocritamente motivata con ragioni “umanitarie”
cui è stata incollata anche la nuova ideologia neoliberale del diritto incondizionato di
abbattere i “dittatori”. Il “moralismo giudiziario”, inaugurato con i processi di Norimberga
e di Tokio (quest’ultimo ancora più sfacciato del precedente) vuole anche la sanzione
processuale dei Cattivi, e questo non è affatto un caso.
Non è affatto un caso, perchè la riduzione del diritto internazionale a diritto penale rivolto
verso i “dittatori” (qui non c’è differenza fra Milosevic, Saddam Hussein e Gheddafi, perchè
tutti e tre vengono simbolicamente “hitlerizzati” per poterne legittimare il trascinamento in
giudizio) non è che la conseguenza di quella privatizzazione della vita sociale cui abbiamo
già entrambi ampiamente fatto riferimento in una conversazione precedente. Sulla base di
questo criterio, Napoleone non sarebbe finito a Sant’Elena, ma sarebbe stato processato
da una corte penale inglese, russa, austriaca e prussiana. Cavour e Bismarck sarebbero
stati certamente processati, perchè non c’è dubbio che nel perseguire le loro finalità
politiche (rispettivamente l’unificazione dell’Italia e della Germania) commisero certamente
crimini penali di ogni tipo. La storia deve quindi ritenersi conclusa (vedi l’ideologia
imperiale americana di Francis Fukuyama sulla fine della storia), e conclusa in una
globalizzazione finanziaria generalizzata e guida militare e geopolitica americana. In
questo quadro il “pubblico” è ridotto a economia (più esattamente, a crematistica), e tutto il
resto è privatizzato, civilmente o penalmente.
Il discorso sarebbe lungo, e non può essere fatto in questa sede per ragioni di spazio.
Conviene invece limitarsi ad un punto solo, del resto da te bene individuato, che è la
vergognosa impotenza e connivenza del cosiddetto “pacifismo”.
Del pacifismo (chiamato a volte in modo classicistico “irenisno”) sono state date molte
definizioni, che a volte complicano le cose anzichè chiarirle. In questa sede per ragioni di
brevità e di chiarezza, mi limiterò a segnalarne due. In primo luogo, esiste un pacifismo
assoluto, che però a scanso di equivoci è bene definire subito come “non-violenza”, e che
non ha nulla e che fare con il berciare “pace, pace” in irrilevanti cortei ai cui fianchi
esagitati in passamontagna danno fuoco a cassonetti e spaccano vetrine in genere
ampiamente assicurate, nutrendo così le assicurazioni e lo spettacolo mediatico. La nonviolenza
è una tecnica politica individuale e collettiva, rivolta ad ottenere scopi, e deve
essere giudicata esclusivamente dal fatto se questi scopi vengono o no ottenuti, non certo
dal salmodiare pecoresco di belanti dipinti (vedi Gandhi, eccetera.). In secondo luogo,
possiamo chiamare pacifismo la risoluzione pacifica di conflitti originariamente violenti ed
addirittura armati in cui le due parti vengono chiamate intorno ad un tavolo di negoziazione
in presenza di un arbitro imparziale. Nel caso della Libia 2011, il solo “pacifista” degno di
questo nome è stata l’organizzazione dell’Unità Africana, il cui tentativo di mediazione è
fallito a causa del fatto che una delle due parti, che stava per perdere sulla base delle sue
sole forze, puntava ad una vittoria totale dato l’appoggio dei bombardamenti USA e
NATO. Non chiamo invece “pacifisti, perchè non lo sono in alcun modo, gli interventisti
“umanitari” violatori del diritto internazionale, che dovrebbero essere connotati invece
come “guerristi”, se le parole avessero ancora un senso non del tutto “colonizzato” dalla
manipolazione semantica del potere.
Mi congratulo con il tuo coraggio morale quando dici che occorre schierarsi sia con
Gheddafi che con Saddam, e non con le loro discutibili persone, ma come rappresentanti
legittimi di stati sovrani. Questa è esattamente anche la mia posizione. Sono stato con
Milosevic (1999) e con Saddam (2003), e sono oggi con Gheddafi (2011). In questo modo
viene colto il punto cruciale della questione, che sta nella illegittimità e nella infondatezza
(sia politica che morale) della pretesa dell’assolutezza del diritto arbitrario sul principio
dell’interventismo umanitario. Per avere un senso, il termine di “interventismo umanitario”
deve essere ferreamente limitato ai terremoti, alle catastrofi nucleari, agli tsunami, alle
carestie, ed a tutto ciò in cui è in gioco la solidarietà fra individui, popoli e nazioni.
L’interventismo militare geopolitico che si traveste da intervento umanitario (falsificando
anche le risoluzioni ONU, che parlavano solo di no-flight-zone, e non di diritto al
bombardamento con intervento unilaterale in una guerra civile fra libici) è invece sempre e
solo “guerrrismo”, ed in nessun modo “pacifismo”. Ma allora, che cosa muove le
cornacchie di “sinistra” interventiste, Pietro Ingrao, Rossana Rossanda, Dario Fo, Franca
Rame, eccetera (non parlo qui certo di Giorgio Napolitano, esponente organico della
subordinazione italiana agli USA ed alla Nato)?
Si è trattato di un impazzimento collettivo? In parte sì. Certamente, di un impazzimento
ideologico generalizzato. Ci può aiutare la scuola di Palo Alto in California (Berkeley), che
studia le psicosi dei bambini, sulla base dei messaggi contraddittori che ricevono dai
comportamenti contraddittori dei loro genitori, e che non sanno ovviamente padroneggiare,
decifrare ed elaborare. Tutta questa gente “di sinistra” non aveva mai considerato un
“valore” la sovranità nazionale, in nome della astratta solidarietà internazionalistica su
base puramente classista. Adesso questi sventurati hanno semplicemente rovesciato il
vecchio nichilismo nazionale a base anarcoide (per cui i ribelli hanno sempre ragione
contro un fantomatico “potere”, indipendentemente dal loro concreto programma politico e
sociale, che può essere ben peggiore di quello del potere precedente) in cosmopolitismo
astratto di generici “diritti umani” a base moralistica. Ma torniamo all’esempio dell’impazzimento
sulla base della mancata elaborazione di messaggi contraddittori. Da un lato,
questi fallimentari disgraziati recepiscono il messaggio dei mass media occidentali in
modo pressoché integrale e non filtrato da un metodo critico (Milosevic macellaio dei
Balcani, Saddam Hussein dittatore sanguinario, Gheddafi ridicolo tirannello amico di
Berlusconi, eccetera). Dall’altro, e contraddittoriamente, dopo aver recepito l’immagine del
Crudele Dittatore con simbolici baffi alla Hitler-Stalin, devono però belare “pace, pace” in
nome del riferimento astratto al pacifismo. Ma questi belati non possono resistere al
fascino della teoria dei diritti umani, pilastro del Politicamente Corretto con cui questi
sventurati (a mio avviso più degni di pietà che disprezzo) hanno sostituito il precedente
Operaismo Mistico (viva la FIOM) ed il precedente Culto del Guerrigliero Eroico (viva Che
Guevara). L’impazzimento ideologico che ne consegue, come nel caso dei bambini curati
a Palo Alto, li ha portati a gridare: “Viva la Pace! Uccidete il sanguinario dittatore, anche
con i bombardamenti USA e NATO, se necessario!!”.
C’è una lezione da trarre da tutta questa grottesca e triste storia? Certo che c’è. La lezione
consiste in ciò, che il pacifismo non può essere agitato in modo astrattamente ritualistico,
ma richiede una fortissima base teorica, filosofica politica e morale. Occorre ricominciare a
riconoscere l’aspetto principale e l’aspetto secondario dei problemi, e chiedersi come é
possibile che i responsabili della dittatura delle oligarchie crematistiche siano nello stesso
tempo i difensori dei diritti umani degli individui, dei popoli e delle nazioni. Il vergognoso
tradimento della parola data (il patto d’amicizia fra Italia e Libia) è stato unanimemente
avallato in Italia da tutta indistintamente la destra e la sinistra parlamentari, che hanno così
ancora una volta mostrato alla luce del sole quella che per molti è ancora una tesi
discutibile ed azzardata, e cioè l’attuale tramonto della dicotomia Destra/Sinistra. Che
cosa ci vorrà ancora perchè si cominci a capire quella che è ormai sotto gli occhi di tutti, e
cioè l’omologazione degli estremi bipolari precedenti in un Estremismo di Centro a
sorveglianza mediatico-universitaria ed a permanente minaccia di bombardamenti NATO?
2. Non esistono oggi né partiti né movimenti politici capaci di interpretare il comune
sentire, inteso come insieme di valori morali e culturali diffusi che nella società si
contrappongano ad un ordine democratico, caratterizzato dall’assenza di
fondamenti etici su cui possano legittimarsi le istituzioni degli stati. Il fenomeno
della globalizzazione economica in atto, ha ridotto drasticamente la sovranità degli
stati ed ha anche mutato profondamente la cultura dei popoli. Le identità nazionali
hanno ceduto il passo al cosmopolitismo globale, alle differenziazioni culturali e
linguistiche si sono sostituite nuove forme di uniformazione culturale specie nei
costumi, nel modo di sentire comune, per lo più plasmato dalla virtualità
dell’immagine erogata dai media. L’umanità sembra evolvere verso forme di
omologazione del pensiero e del sentire che si impongono nel mondo non
unificandolo, ma trasformando l’umanità stessa in un agglomerato cosmopolita
globale. Il globalismo indifferenziato non richiede certo adesione e consenso, ma si
impone sia con le armi che con la cultura e l’economia dei consumi. Il globalismo
non comporta le scelte morali e le valutazioni del pensiero critico, ma investe tutti in
un unico processo che viene inteso dalla generalità delle masse come necessario
ed ineluttabile destino. Pertanto, in tale contesto è facilmente spiegabile
l’indifferentismo morale generalizzato nel nostro presente storico sia dinanzi alle
guerre imperialistiche, che nei confronti di certe scelte di trasformazione sistemica
dell’economia, che comportano l’abrogazione progressiva dello stato sociale, che
nei rapporti interpersonali improntati alle esigenze utilitaristiche dell’individuo. In
questo programmato fluire indifferenziato di eventi, la società non riproduce più sé
stessa, dal momento che è la società stessa ad aver rinunciato ai suoi presupposti
etici che ne assicurassero la sussistenza e la continuità. Una società globale
indifferenziata non può che essere sempre uguale a sé stessa, è la risultante di uno
stato di fatto permanente che non ha quindi alcuna esigenza di riprodursi.
L’economicismo globale ha distrutto inoltre i postulati basilari della stessa ragione
economica. Prevale infatti, al di là dei suoi clamorosi fallimenti, l’economia
finanziaria globale, fondata sui valori virtuali del mercato finanziario,
sull’irrazionalismo delle masse dei consumatori – investitori, a discapito della
produzione, dello sviluppo, della redistribuzione della ricchezza. Un mondo
indifferenziato globale è la conseguenza ultima di un nichilismo diffuso specie
nell’ambito di una cultura, che ha intesa da oltre un secolo prescindere dal pensiero
critico e dal giudizio morale. E’ sintomatico di tale stato di cose, che generalmente,
quando qualcuno voglia esprimere una propria opinione non perfettamente in riga
con il politically correct dominante, premetta al suo discorso che il suo pensiero
non vuole essere un giudizio morale.
Bisogna riflettere sul fatto, apparentemente secondario e minore, ma sintomatico, per cui
la gente si sbriga a dire che quanto dice non vuole essere un giudizio morale. Ciò è tanto
più paradossale, ed apparentemente contraddittorio, quanto più la politica è stata
soffocata dal moralismo degli scandali e dall’esportazione armata dei cosiddetti “diritti
umani”, che essendo appunto “umani” non possono che essere a base morale. Ma si ha
qui appunto a che fare con il fenomeno non tanto della sparizione della morale, che nella
forma del moralismo ipocrita-giudiziario è invece ipertrofica, ma con la fine dell’etica, ed in
particolare dell’etica comunitaria.
La gente non direbbe che quanto dice non vuole essere un giudizio morale se non
percepisse confusamente che c’è intorno una sorta di indiretta pressione sociale
conformistica che “preme” per questa affermazione. Non è facile il capire il perchè. Ma se
vogliamo capirlo, è necessario afferrare le cose alla radice. E la radice, a mio avviso, sta
nella riduzione del concetto di libertà a libertà del consumatore. Il consumatore può infatti
consumare quello che vuole, fino a che l’oggetto del consumo non è dichiarato
esplicitamente illegale (narcotici, pedopornografia, simboli nazisti, eccetera). Prima di
essere caratteristiche dell’ideologia contemporanea diffusa, il relativismo ed il nichilismo
sono caratteristiche organiche della libertà del consumatore, che secondo le curve di
indifferenza dell’economia neoclassica si muove in base alla massimizzazione della
propria “ofelimità” (il termine tecnico per indicare l’utilità personale).
Tutto questo, ovviamente, non è affatto di per sé un male. Finchè ci si muove nell’ambito
della legalità, ognuno ha l’insindacabile diritto sovrano di preferire un consumo ad un
altro. C’è chi preferisce la nuotata in mare, chi l’escursione in montagna, chi infine il riposo
in un agriturismo di campagna. C’è chi acquista libri rari, e chi invece preferisce un bel
viaggio in un paese lontano. Qui ci si muove nella sfera della legittima ragione economica,
ed allora il problema sta nel vedere fino a che punto quello che tu chiami “economicismo
globale” abbia distrutto, insieme con l’etica comunitaria, la stessa ragione economica. In
fondo alla catena scopriremo anche l’ometto che, convinto di essere un esprit fort libero da
vecchi e sorpassati pregiudizi, sostiene che quanto afferma non vuole essere un giudizio
morale.
Tutta la tradizione filosofica occidentale è caratterizzata dal tentativo di fondare il concetto
di libertà in qualcosa che non si riducesse a semplice arbitrio. Persino il termine di “libero
arbitrio”, centrale nelle discussioni teologiche sulla grazia e la predestinazione, è sempre
stato correlato al corretto uso di questo stesso libero arbitrio, rivolto verso il Bene ed il
Giusto e non verso il Male e l’Ingiusto. Il processo che Karl Polanyi ha descritto a livello
storico (l’autonomizzazione dell’economia dalla sua precedente “incorporazione” politica,
sociale e comunitaria) si è per così dire “duplicato” a livello ideologico-filosofico nella
separazione prima e nella assolutizzazione poi, della libertà del consumatore rispetto ad
ogni altro tipo di libertà. Da circa trent’anni, all’interno della cosiddetta
“deideologizzazione”, lo stesso elettore è trattato come un consumatore di prodotti politici
preconfezionati nel mercato politico (campagne elettorali personalizzate, sondaggi
praticamente indistinguibili dai sondaggi commerciali, eccetera).
Nella tradizione filosofica occidentale moderna il concetto di libertà è stato declinato in
due modi fondamentali, quello del criticismo di Kant e quello dell’idealismo di Hegel. In
Kant la libertà (più esattamente il libero arbitrio) è declinata come un postulato a priori
della ragion pratica, cioè del comportamento morale umano libero. Il soggetto kantiano è
però “puro” ed astratto, e cioè integralmente destoricizzato e desocializzato, ed in questo
modo il campo dell’etica, comunitario per definizione, è integralmente ridotto a campo
della morale individuale. L’etica è allora di fatto soltanto la sommatoria di singole morali
individuali. Sebbene Kant non ne fosse probabilmente consapevole, e fosse mosso dalle
migliori intenzioni illuministiche, anti-feudali, anti-signorili ed anti-assolutistiche, questa
estrema individualizzazione della morale non faceva che “duplicare” in campo filosofico
l’analoga (e storicamente coeva) individualizzazione del comportamento economico
effettuata da Adam Smith, anche se superficialmente il rigorismo dell’imperativo categorico
kantiano non aveva nulla a che fare con la cosiddetta “etica della simpatia” fra venditore e
compratore, che Kant avrebbe considerato eteronoma e non autonoma, e quindi nel suo
linguaggio non completamente “morale”. Ma qui si ha a che fare con quella fisiologica
schizofrenia del grande pensiero borghese classico, che in seguito diede poi luogo alla
famosa “coscienza infelice”.
Il grande idealismo classico tedesco (i cui principali esponenti sono stati nell’ordine Fichte,
Hegel e Marx, che non è affatto stato un filosofo materialista, ma integralmente idealista,
sia pure in modo molto peculiare) nasce come critica dell’individualismo astratto di Kant, e
prende di mira in particolare i suoi aspetti strutturali di destoricizzazione e di
desocializzazione. La destoricizzazione e la desocializzazione non erano state per nulla
degli “errori” di Kant, ma erano state ingredienti indispensabili per effettuare la rottura con
le precedenti fondazioni organicistiche delle società feudali e signorili e per poterle
sostituire con la concezione di una nuova società liberale-borghese costituita da individui
autonomi, liberi ed indipendenti. L’intera filosofia detta “moderna”, da Cartesio (il cogito) a
Kant (l’Io Penso), doveva iniziare con una costituzione formalistica del soggetto,
destoricizzato e desocializzato, perché solo in questo modo si “spianava la strada” alla
società degli individui del tutto auto-fondati economicamente e moralmente. Hegel vuole
invece ristabilire il rapporto fra filosofia e comunità, già magistralmente posto dai maestri
greci, ma nello stesso tempo è consapevole di non poter “restaurare” il modello idealistico
di Platone (di origine geometrico-pitagorica), perché nel frattempo il cristianesimo
monoteistico, che egli rifiuta di considerare in termini di semplice superstizione e
decadenza (come faranno dopo di lui i positivisti e Nietzsche), ha introdotto la nozione di
coscienza storica, più o meno diversamente secolarizzata.
In opposizione a Kant, per cui la libertà è un postulato a priori di una soggettività
individuale integralmente destoricizzata e desocializzata (la cui astrazione corrisponde al
carattere “astratto” del lavoro capitalistico), per Hegel la libertà è un risultato, un
conseguimento, il risultato finale di un processo storico e sociale di autocoscienza della
libertà. Su questo punto non esiste nessuna differenza filosofica fra Marx ed Hegel, anche
se ovviamente Marx era comunista e Hegel non lo era. L’individuo non è affatto cancellato
o umiliato, al contrario. Semplicemente, esso non è assolutizzato, ed in questo modo non
è posto astrattamente come vuota origine del Bene e del Male. L’individuo è correlato alla
comunità di appartenenza, e si tratta allora di vedere se questa comunità di appartenenza
sia o meno portatrice di valori universali, universalistici o universalizzabili. E qui viene non
solo criticato quello che Marx chiamerà “robinsonismo”, nella duplice forma filosofica di
Kant ed economica di Smith, ma viene espresso un concetto di libertà comunitario
complessivo, che in quanto tale è incompatibile con il riduzionismo alla sola libertà del
consumatore.
La libertà del consumatore si basa su di un pedigree filosofico alternativo, quello di Hume
e di Nietzsche, ereditato oggi da Faucault e da Toni Negri. Per Hume la libertà rimanda
ad un soggetto che non è che un flusso variopinto di emozioni e di sensazioni, ed è
pertanto il soggetto ideale per l’attuale seduzione consumistica del mercato pubblicitario.
D’altra parte, per Hume la società non ha bisogno di essere fondata sull’esistenza di Dio,
sul diritto naturale e sul contratto sociale, ma basta ed avanza il semplice rapporto di
abitudine fra individui. Il sulfureo Nietzsche riprende integralmente la concezione
antropologica del soggetto di Hume, in quanto il soggetto per Nietzsche non è che il flusso
energetico della volontà di potenza. L’attuale concezione post-moderna della libertà del
consumatore unifica genialmente Hume e Nietzsche, emargina quella di Kant (considerata
troppo moralistica e ritenuta valida soltanto per seminari universitari esplicitamente rivolti
contro la concezione comunitaria derivata da Hegel e poi da Marx), e si oppone
frontalmente alla concezione di Hegel e di Marx, bollati come nemici della “società aperta”
di Popper, non a caso diventato oggi il papa filosofico del capitalismo anglosassone.
Società aperta che poi non è “aperta” per nulla, ma anzi è chiusissima, perché si basa sul
presupposto della fine capitalistica della storia.
Come si vede, una corretta diagnosi dell’odierno indifferentismo morale, generalizzato,
ipocritamente unito ad un continuo moralismo asfissiante, non può evitare di risalire alle
origini dell’individualismo borghese moderno. Il comunismo storico novecentesco
recentemente defunto (1917-1991) non ha potuto e saputo in alcun modo contrapporvisi,
perchè le comunità non possono essere imposte artificialmente in modo dispotico, ed il
dispotismo, in questo simile al latte, ha una vera e propria “data di scadenza”, che coincide
con l’avvento di nuove generazioni storicamente estranee ai movimenti politici e sociali
che hanno dato luogo a questi “dispotismi sociali”. Così come avvenne per il dantesco
“contrappasso”, viviamo in un periodo storico in cui la diffusione dell’individualismo
anomico è stata ideologicamente rilegittimata da questo crollo. La sola cosa sicura, però, è
che si tratta di un fenomeno temporaneo e provvisorio.
3. Quando si evoca l’indifferentismo morale, in occidente il riferimento corre
immediato al conformismo delle masse, drogate dal consumismo indotto dallo
strapotere dei media della persuasione collettiva. Una socialità in cui prevale
l’indifferenza generalizzata non è tale. E’ assai facile per un intellettuale organico
emettere giudizi di condanna morale sulle masse che non intendono il suo verbo e
lamentare la sua emarginazione. Ma l’intellettuale emarginato dalle masse, che non
interpreta il senso comune dominante nella società n cui vive è una figura priva di
senso nel contesto sociale in cui vive. La radice dell’indifferentismo morale della
società odierna è da ricercarsi, sia dal punto di vista storico che filosofico
nell’individualismo. Anzi, l’indifferentismo morale delle masse è la conseguenza
ultima di un processo di dissociazione tra l’individuo e la società affermatosi
storicamente da almeno due secoli. Occorre infatti risalire alla genesi
dell’individualismo per comprendere la logica storico – filosofica da cui scaturisce
l’indifferentismo morale odierno. E’ infatti lo sgretolarsi progressivo dell’etica
comunitaria a produrre la morale, intesa come l’etica individuale di un uomo
dissociato dalla società e dai valori comuni di riferimento. Che poi la morale si
legittimi attraverso il primato del pensiero trascendentale (kantismo), oppure tramite
il primato della coscienza individuale (protestantesimo),la differenza non è così
rilevante: in entrambi i casi l’uomo, espropriato della suo dimensione sociale,
isolandosi dalla comunità, incardina i suoi valori in entità estranee all’uomo stesso.
Il pensiero critico è soppiantato da direttive di comportamento cui l’io deve
adeguarsi. Il precetto morale si sostituisce alla dialettica del confronto sociale
perché l’individuo diviene l’unica fonte di legittimazione di sé stesso. Quindi
all’individualismo morale succede l’individualismo prima empirista poi illuminista
che, negando al pensiero filosofico ogni fondamento metafisico, elimina dunque
ogni causalità e finalità presupposta all’individuo, che diviene in tal modo unica
causa di sé stesso e del proprio agire. Una volta ristretti gli orizzonti del pensiero ad
un agire fattuale determinato dall’utilità individuale e degradati i rapporti sociali a
rapporti economici di scambio di merci e servizi, è evidente che le problematiche
inerenti il giudizio etico – morale di sé stessi e della società appaiono
determinazioni prive di senso. La metafisica e la assiologia si sono trasformate in
psicologia individuale e di massa, sedimentata ormai la relatività del proprio essere
individuale e della stessa storia, ridotta nei limiti temporali dell’esistenza, si è
realizzata la dissoluzione dell’io, che si è sciolto nell’acido dell’indifferentismo
morale di un individualismo massificato, che non è e non vuole essere una nuova e
diversa filosofia dell’essere dell’uomo contemporaneo, ma la negazione stessa di
ogni dimensione etico – morale che conferisca senso alla vita stessa.
La colpevolizzazione aristocratico-snobistica delle masse rappresenta una facile via di
fuga per i cosiddetti “colti”, la cui cultura non gli permette però di capire che il consumismo
non è un prodotto spontaneo che viene “dal basso”, ma una forma di integrazione
artificiale integralmente gestita dai dominanti sui dominati. D’altra parte, la recente
dissoluzione del comunismo novecentesco recentemente defunto deve pur sempre
servirci da lezione, ed insegnarci che la compressione dei consumi individuali non è in
alcun modo una forma di moralizzazione, e tantomeno di ricostruzione etica comunitaria,
ma soltanto una forma di anomia che poi porta al suo contrario, il riscatenamento
dell’individualismo consumistico (ed in questo l’esempio della Cina dovrà pur sempre
essere preso in considerazione).
Nel colpevolizzare le masse per la loro presunta “volgarità” si distinguono i cosiddetti
“gruppi intellettuali”. Hai perfettamente ragione, e non posso che congratularmi con te, nel
segnalare che è assai facile per un intellettuale (organico ma non solo) emettere giudizi di
condanna morale sulle masse che non intendono il suo verbo e lamentare la sua
emarginazione. In questa mia terza risposta, quindi, mi limiterò ad esaminare il rapporto
fra gli attuali gruppi intellettuali e le forme dominanti di individualismo. Queste forme
derivano dalla società di mercato, e ci sarebbero anche se per ipotesi i gruppi intellettuali
non esistessero. Ma le forme attuali della riproduzione sociale degli intellettuali, e
soprattutto della loro visibilità pubblica (giornalistica, televisiva, ma in primo luogo e
sopratutto universitaria) sono comunque un fattore da prendere in considerazione.
I saggi che studiano la storia ed il ruolo dei gruppi intellettuali sono molto numerosi, ed io
stesso ne ho scritto uno (cfr. Il ritorno del clero, Editrice CRT, Pistoia 2000). Tuttavia
quello che imposta a mio avviso meglio i termini storici e filosofici della questione è stato
scritto da Zygmunt Bauman, ed è il suo capolavoro (cfr. La decadenza degli intellettuali,
Bollati Boringhieri, Torino 1992 e 2007). Anziché riassumerne semplicemente le tesi, le
rielaborerò autonomamente partendo da esse, per sviluppare poi il mio punto di vista, che
ritengo in gran parte convergente con il tuo.
Bauman individua la genesi storica di uno specifico gruppo sociale definibile come
“intellettuali” nei philosophes, cioè negli illuministi francesi del Settecento europeo, e li
connota come “legislatori sociali”, almeno in pectore. Gli intellettuali sarebbero quindi nati
nel Settecento, e sarebbero nati come legislatori sociali. Si tratta di una ipotesi del tutto
plausibile, che si contrappone ad altre due scuole di pensiero. La prima parla di
“intellettuali” in tutti i casi in cui una società produce dei mediatori culturali la cui funzione
è quella di produrre un mondo simbolico di integrazione sociale, ed in questo caso bisogna
risalire agli scribi egizi, ai cantori scandinavi, ai filosofi cinesi, indiani e greci, ai profeti
ebraici, eccetera, con il pericolo di produrne in questo modo una nazione talmente ampia e
generica da risultare di fatto inutilizzabile, come le maglie di una rete talmente grandi da
non poter prendere i pesci, perchè questi ultimi ci passano attraverso. La seconda limita la
nascita di veri e propri gruppi intellettuali ad un fatto molto recente avvenuto a fine
Ottocento, il caso Dreyfus e la reazione organizzata (Zola, eccetera) all’antisemitismo
moderno, con il pericolo però di produrre una nozione talmente limitativa di “intellettuali” da
renderla non euristica e non operativa per ragioni opposte ma convergenti con la
precedente. L’ipotesi di Bauman è invece plausibile perchè correla strettamente il gruppo
sociale degli intellettuali in quanto specialisti dell’universale e del simbolico con l’emergere
della borghesia come classe sociale specifica, di cui il proletariato non è tanto la
negazione ed il superamento, come ha scorrettamente opinato il marxismo ottocentesco e
novecentesco, quanto un correlato organico e complementare, che nasce con essa, si
sviluppa con essa, e tramonta con essa. Vi è pertanto un primo elemento che possiamo
trarre da Bauman: il gruppo sociale degli intellettuali sorge insieme con la borghesia e con
il suo complemento necessario chiamato proletariato, e con lo sviluppo progressivo di un
capitalismo post-borghese, e quindi post-proletario, è normale che non possano più
esistere nella vecchia forma consueta, e questo fa venir meno tutte le teorie precedenti, da
Voltaire a Mannheim, da Husserl a Gramsci, eccetera.
Ma qui il diavolo, si nasconde nel dettaglio, e cioè in una paroletta apparentemente
inoffensiva. Gli intellettuali, in questo caso i filosofi non sono nati come legislatori sociali
ma come legislatori comunitari. Non è affatto la stessa cosa. Il termine “società” non esiste
neppure in greco antico, e non esiste perchè non ne esiste neppure il concetto e la realtà,
ma c’è soltanto il termine di comunità (koinòn, koinonia). Lo stesso termine latino di
societas non è di fatto mai impiegato nel senso che oggi diamo a questa parola. La
“società” è un termine generico, la cui ipertrofia sociologica nasconde una
indeterminatezza patologica. Il “sociale” è un concetto ampio, che manca però di forza
esplicativa, se non ne viene prima posta la sua genesi ontologica, che è sempre una
ontologia storica. Per ora le scienze cosiddette “sociali” tendono a spiegare i fenomeni
sociali con altri fenomeni sociali, ed in questo mondo si crea una catena viziosa,
autoreferenziale e tautologica simile ad un serpente che si morde la coda. Ma cos’è, in
ultima istanza, l’elaborazione del sociale? Non è nulla, se non si capisce che il “sociale”
deve essere spiegato al di fuori di esso, e non è che una metafora impropria di ciò che
dovrebbe invece essere definito come “storicità”. Finchè si continuerà a pensare gli
intellettuali come “legislatori sociali”, e basta, ci si muoverà sempre in un cerchio magico
incantato in cui i concetti, come in un girotondo senza fine, si richiamano sempre e solo
l’uno con l’altro.
I primi filosofi greci, che pure a mio avviso sarebbe scorretto definire come “intellettuali”,
non erano legislatori sociali, ma erano legislatori comunitari. Una pigra abitudine inerziale
consolidata ci ha portato a pensare che fossero semplicemente dei “naturalisti”, e cioè dei
precursori artigianali dei moderni fisici, chimici e biologi. Ma non è così. In assenza di una
religione monoteistica e creazionistica rivelata, e pertanto in assenza di quella funzione
profetica diffusa presso gli Ebrei, i primi filosofi greci dovevano affermarsi come autorevoli
e credibili nella loro comunità esclusivamente attraverso l’interpretazione della genesi della
Natura, in quanto la stessa comunità sociale era pensata come duplicazione della natura
stessa, sulla base dell’originaria indistinzione fra macrocosmo naturale e microcosmo
sociale ed umano. Con l’irrompere della moneta coniata e della sua tesaurizzazione
potenzialmente illimitata (apeiron), la precedente comunità era messa in pericolo dal
potere delle ricchezze individuali e soprattutto dalla schiavitù, per debiti. Per questo era
necessario il calcolo comunitario equilibrato del potere e della ricchezza (logos), e questo
è il significato fondamentale del termine logos, che soltanto in seconda istanza significa
linguaggio o ragione discorsiva.
Gli intellettuali ottocenteschi e novecenteschi riprendono quindi questa funzione di
legislazione comunitaria, e questo è un loro titolo di merito, non certo di demerito, come
affermano i post-moderni che li accusano di essere caduti vittime della cosiddetta
“sindrome di Siracusa”, alludendo a Platone che si sarebbe illuso di poter fare da
consigliere ai tiranni. Ma qui c’è soltanto la reazione congiunturale all’ipertrofia della
ideologizzazione politica del ventennio, 1960-1980, il cui lutto non è stato ancora elaborato
se non nella forma del pentimento.
La fine della funzione intellettuale si accompagna con la visibilità mediatica ossessiva di
intellettuali conferenzieri, simili ai Luciano ed agli Apuleio del tardo impero romano. La
cultura diventa integralmente spettacolo con la passivizzazione dello spettatore. Diventati
specialisti universitari attraverso la esasperata divisione accademica delle discipline
(funzionale alla moltiplicazioni di cattedre, dipartimenti e finanziamenti), gli intellettuali non
solo si suicidano, ma si riproducono solo attraverso la cooptazione conformistica delle
cattedre universitarie. Mentre per diventare poliziotti, magistrati o insegnanti di scuola
media ci vogliono pur sempre concorsi selettivi in busta chiusa in cui vengono corretti testi
rigorosamente anonimi, i concorsi universitari (parlo qui ovviamente solo delle facoltà di
filosofia e di scienze sociali) vengono effettuati sulla base dell’integrale cooptazione, in cui
il conformismo ideologico politicamente corretto fa premio su qualsiasi altra forma di
merito, nonostante l’ipocrita e ritualistico richiamo ad una inesistente “meritocrazia”.
Questo fa diventare gli intellettuali (parlo non del singolo, che può anche cantare fuori dal
coro, ma del gruppo sociale in quanto tale) uno dei gruppi sociali più conformisti ed
“integrati” dell’intero orbe terracqueo. Se oggi il codice dominante è quello individualistico
della libertà del consumatore, possiamo essere sicuri che i gruppi intellettuali mediatici ed
universitari se ne faranno portatori, non tanto nella forma esplicita e diretta (demandata ai
pubblicitari), quanto nella forma indiretta della sistematica diffamazione di tutte le forme di
pensiero non omogenee a quest’ultimo, non importa se di destra (Ezra Pound) o di sinistra
(Karl Marx). Gli intellettuali sono oggi portatori di quello specifico estremismo di centro che
possiamo definire conformismo post-moderno. Possiamo aspettarci qualcosa di buono
dalle cosiddette “persone normali”, ma da essi intesi come gruppo sociale sicuramente no.
4. L’economia di mercato e soprattutto la società di mercato ad essa collegata,
quale complesso di rapporti sociali derivati dalla logica mercatista, produce sempre
nuovi equilibri dinamici in cui trovano il loro punto di equilibrio sia la domanda e
l’offerta di beni e servizi, che la composizione dei rapporti sociali, morali e culturali
tra le classi. Così come nel mercato si manifestano le crisi economiche, quali
momenti di trasformazione in cui il mercato tende a creare nuovi parametri di
equilibrio, anche la struttura della società tende ad evolversi parallelamente.
Pertanto, da tali mutamenti emergono alcune classi sociali, cui corrisponde il
declino di altre. Questo processo dinamico – evolutivo dell’economia di mercato,
determina dunque sempre nuovi equilibri ai quali è la società che deve adattarsi e
mai l’economia. La nuova struttura dei rapporti sociali che ne deriva è dominata da
quelle classi sociali che si siano rese compatibili con le evoluzioni del mercato con
conseguente estromissione delle altre. Il capitalismo del XXI° secolo tende ad una
accentuata logica selettiva ad excludendum, con l’effetto di marginalizzare sempre
più vasti strati del tessuto sociale, che vengono progressivamente esclusi dai nuovi
equilibri socio – economici. La selezione effettuata dal mercato determina
marginalizzazioni e disuguaglianze sempre più accentuate nel corpo sociale, mai
l’integrazione e l’eguaglianza tra le diverse componenti della società. Oggi
assistiamo con la crisi sistemica in atto sia alla emarginazione delle masse nei
paesi evoluti dell’occidente, che dei popoli del terzo mondo nell’ambito geopolitico.
L’emarginazione conduce all’isolamento sia individuale che collettivo di masse
umane che non si riconoscono nelle istituzioni, in quanto prive di un ruolo attivo
nella società sia nel campo economico che in quello politico. Quindi si afferma un
indifferentismo morale di massa derivato da una condizione umana non sorretta da
valori morali che giustifichino gli equilibri sociali selettivi e disgreganti della società
globalizzata del nostro tempo. L’emarginazione sociale comporta l’emergere di una
logica della sopravvivenza generalizzata, derivante dallo stato di precarietà
economica nel campo lavorativo ed esistenziale nei rapporti interpersonali. In tale
condizione l’uomo non tende al sovvertimento sociale, ma alla conservazione
dell’esistente: una vita precaria, concentrata sulla sopravvivenza genera solo istinto
di conservazione. Non è un caso che nella società occidentale prevalgano le
tendenze politiche conservatrici: l’estromissione delle masse da una politica
dominata dalle oligarchie delle lobbies ha prodotto ha determinato l’indifferentismo
morale quale condizione di estraniazione esistenziale dell’io sia dalla propria
identità che dal mondo in cui vive. Indifferentismo morale e conservatorismo
dell’esistente sono fenomeni paralleli che tendono ad identificarsi a vicenda. Perché
considerare la propria sostanza umana solo alla luce della realtà positiva
contingente, conduce fatalmente alla accettazione dell’esistente. Analoghi sviluppi
subisce la cultura dominante, che oggi appare concentrata nella condanna morale
di tutti quei fenomeni non del tutto compatibili con la logica relativista di
conservazione dell’ordine anomico dell’esistente (diritti umani, liberaldemocrazia,
individualismo). L’indifferentismo morale rappresenta dunque la fase terminale di
un processo degenerativo di una condizione umana che precipita nell’abisso del
suo non essere, inteso come non essere di se stessi, sia dal punto di vista
individuale che collettivo.
Ritengo che tu abbia individuato il cuore del problema del nostro tempo affermando che
oggi la società deve adattarsi all’economia, e non certo l’economia alla società. Si dirà (e
sono soprattutto i marxisti a dirlo) che questa non è una novità, perchè questo è sempre
avvenuto, e sempre la società (o più esattamente la comunità) ha dovuto adattarsi
all’economia. Ma non è vero. Se per “economia” si intendono le risorse naturali, le forze
produttive, l’agricoltura, l’allevamento, eccetera, allora questo può essere parzialmente
vero (parzialmente, ma non del tutto, perchè ambienti naturali simili hanno prodotto
configurazioni storiche e sociali, molto diverse e talvolta alternative). Ma oggi l’economia
non è più questo, quanto l’imposizione diretta di una forma obbligata politica, culturale e
sociale autoreferenziale. Si tratta di una relativa “novità”. Questa novità deve essere
indagata con categorie specifiche adatte ad essa.
Per comprendere il cuore del problema da te messo a fuoco con tanta chiarezza
un’eccessiva erudizione storica ed economica può addirittura essere fuorviante, per il noto
principio per cui occorre prima vedere le foreste, e poi esaminare i singoli alberi. Sono
invece necessari due concetti fondamentali, il primo elaborato da Karl Marx, il secondo da
Karl Polanyi. Secondo Marx il capitalismo, o più esattamente il modo di produzione
capitalistico, è retto da una norma di produzione e riproduzione illimitata, ed è proprio
questa illimitatezza l’elemento differenziale e contrastivo con tutti i precedenti (e forse i
successivi, se ci saranno successivi, cosa che nessuna filosofia della storia
necessitaristica, deterministica e teleologica può garantire a priori in forma messianica,
ricoperta o meno con una presunta veste “scientifica”) modi di produzione che hanno
caratterizzato la storia universale dei cinque continenti. Secondo Polanyi il capitalismo è
la sola società in cui l’economia non sia contenuta ed “incorporata” nella più ampia
produzione sociale e comunitaria, e questa non-incorporazione è ovviamente la premessa
non solo dell’autonomizzazione patologica dell’economia stessa, ma del suo soffocante
dominio su tutti gli ambiti della vita sociale, per cui a poco a poco, la fisiologica economia
di mercato diventa una patologica società di mercato.
Partendo dall’economia politica intesa come disciplina indipendente, in tutte le sue varianti
di destra, di centro e di sinistra, questa comprensione è impossibile, ed è impossibile per
l’autoreferenzialità della stessa scienza economica, che si basa sul presupposto
antropologico dell’individuo originario, prima produttore e poi consumatore. E’vero che a
volte si parla di macro-economia contrapposta a micro-economia, ma si tratta quasi
sempre di un espediente, perchè le stesse grandezze macro-economiche disaggregate
rimandano in ultima istanza alla sacralità indiscussa della fondazione utilitaristica
originaria.
L’economia politica trova quindi il suo fondamento ontologico ultimo in una metafisica
dell’individuo originario. Per questo fanno ridere (ma si ride per non piangere!) tutte le
affermazioni alla Habermas o alla Rorty, per cui oggi noi vivremmo finalmente in una
situazione post-metafisica, in cui il rischiaramento illuministico ha finalmente vinto sulle
precedenti superstizioni religiose e su quei succedanei religiosi imperfettamente
secolarizzati che rinviano al pensiero di Hegel e di Marx.
Chi cerca in tutti i Modi nell’economia politica la chiave per la comprensione della totalità
sociale non la troverà mai, perchè l’economia politica non è la soluzione, ma è il problema.
Una delle ragioni - non l’unica, certamente - del fallimento del marxismo storico nella
comprensione del problema della riproduzione della totalità capitalistica sta nel fatto che a
partire da Engels (ma con qualche minore responsabilità di Marx) il marxismo si è
costituito come “economia politica di sinistra” e come previsione pseudo-scientifica e
quasi-religiosa del crollo del capitalismo per opera del soggetto demiurgico proletario. Ma
l’economia politica, di destra o di sinistra che sia coincide al cento per cento con
l’utilitarismo, ed essendo l’utilitarismo una metafisica dell’individuo originario é del tutto
impossibile sulle sue basi giungere alle dinamiche della dissoluzione e della
ricomposizione della comunità. Solo la filosofia può arrivarci, e non è un caso infatti che a
partire dal 1803 circa Hegel abbia individuato nella filosofia l’unica leva per la
ricomposizione della comunità, abbandonando le precedenti generose posizioni giovanili
(l’arte, il cristianesimo, la grecità, eccetera) .
Alcuni economisti sensibili ed intelligenti hanno peraltro capito a loro modo quanto sto
dicendo, e cioè che sul terreno della sola economia è del tutto impossibile ricostruire la
totalità sociale, e pertanto modificarla in una prospettiva concreta e realistica. Fra questi
spicca l’economista-filosofo italiano Claudio Napoleoni (1924-1988). Studiando la storia
del pensiero economico, e non dimenticando mai che quella che viene chiamata “socialità”
non è altro che storicità, o se vogliamo una configurazione mobile e provvisoria della
storicità stessa, Napoleoni giunse alla comprensione della identità in ultima istanza fra la
teoria economica del valore e la teoria filosofica dell’alienazione. E mentre per il suo
compagno di strada Lucio Colletti questa scoperta fu l’occasione (o meglio, il pretesto) per
giustificare il proprio abbandono della prospettiva di Marx e la propria “conversione” al
liberalismo di Popper, per Napoleoni fu invece il punto di partenza per un ripensamento
radicale dell’intera economia politica (cfr. Discorso sull’economia politica, Boringhieri,
Torino 1985), e quindi per una uscita ragionata dalla sua assolutezza autofondata.
Personalmente, ne scrissi in proposito un commento per la rivisita “Marxismo Oggi”. Nel
1990, due anni dopo la sua morte, furono pubblicate delle sue note intitolate “cercate
ancora” (cfr. Cercate Ancora, Editori Riuniti, Roma 1990). E tuttavia, la stima e la simpatia
umana per la sua persona, da me personalmente conosciuta, non deve impedirmi di dare
un giudizio criticamente negativo sulla sua impostazione della ricerca, che esclude ogni
tipo di salvezza storico-politica, si muove verso la critica della Tecnica (intesa nel senso di
Heidegger come dispositivo anonimo ed impersonale incontrollabile ed immodificabile,
Gestell), accusata di annullare il soggetto e di portare il mondo verso un dominio
incondizionato, per cui il progetto di emancipazione umana sfocia nella sapienziale
conclusione heideggeriana che “solo un Dio ci può ancora salvare”.
In questo modo la generosa esortazione di “cercare ancora” diventa a mio avviso
completamente astratta ed ineffettuale, e sfociare nel vasto mare del pensiero postmoderno,
che non è che la razionalizzazione sofisticata dell’impotenza storica e sociale,
più o meno travestita da disincanto verso le grandi narrazioni (Lyotard, Sloterdijk,
eccetera). Bisogna indubbiamente cercare, ma cercare è del tutto inutile se non si sa dove
cercare, perchè soltanto sapendo dove cercare si può sperare di trovare qualcosa. Qui bisogna
mettersi alla scuola dei cercatori di funghi e dei pescatori, che non sono magari
sicuri di provare quello che cercano, ma sanno che in certi posti è assolutamente sicuro
che non si troverà nulla, mentre in altri è invece probabile che si troverà qualcosa.
Il luogo in cui cercare è a mio avviso perimetrato dai due concetti fondamentali prima
richiamati a proposito di Marx e di Polanyi. Se si crede di poter contestare e criticarne il
capitalismo in nome di una illimitatezza ancora più efficiente o addirittura più “giusta” si
andrà fuori strada, perchè sul terreno della illimitatezza il capitalismo è assolutamente
imbattibile. Questo non comporta automaticamente l’adozione della teoria della decrescita,
che nella forma oggi diffusa (Latouche, Badiale, Bontempelli, eccetera) non mi sembra
convincente, ma comporta la sua presa in considerazione evitando frettolose liquidazioni
in nome del modello liberale di crescita o del paradigma marxista classico, che come ho
detto prima è economicistico, ed è quindi soltanto un povero utilitarismo di sinistra a mio
avviso non riproponibile. La teoria della decrescita mi sembra per ora essere il semplice
rovesciamento non dialettico della precedente teoria della crescita. Capisco bene le
ragioni soprattutto ecologiche ed ambientali che ne possono favorire il successo, ma vi
sono troppi “passaggi” economici, politici e filosofici che questa teoria “salta” perchè si
possa pensare di avere già trovato il bandolo della matassa. Resta il fatto che la norma di
accumulazione illimitata che regge il capitalismo, in particolare nella forma attuale postborghese
e post-proletaria è il cuore da contestare e da criticare. I1 “cercare ancora”,
quindi, significa cercare le forme di aggregazione politica e sociale che possano
“praticamente” infrangere questa patetica e viziosa illimitatezza. Il pensiero greco,
pensiero della misura (metron), della giustizia (dike) e del calcolo politico e sociale
comunitario (logos) può essere in questo infinitamente più “attuale” dello storicismo
marxista o della sapienzialità heideggeriana.
E’ tuttavia la diagnosi di Po1anyi che oggi mi sembra la più ricca di insegnamenti. Finchè
l’economia (di cui non discuto la legittimità sia dell’oggetto che del metodo, se non
vengono assolutizzati in una metafisica utilitaristica dell’individuo robinsoniano originario)
non sarà riportata all’interno del controllo sociale comunitario, inevitabilmente politico, il
popolo non sarà mai al potere, ma resterà sempre un’astrazione ideologica vuota, per cui
la democrazia non potrà mai essere altro che oligarchia e l’economia non potrà mai essere
altro che crematistica.